La bisnonna Maria Besana è una figura di rilievo nella “mitologia” dei Riva. Era soprannominata "Nona Marièt" e veniva da Bernareggio.
Mia
madre ricorda che il vecchio Rolla, detto “al Pota” (di origine
bergamasca?), un uomo alto che le incuteva un po’ di paura e che era
bisnonno del mio quasi coetaneo Mario Pulici, quando la incontrava da
piccolina si divertiva un mondo ad apostrofarla con voce cavernosa e un
po’ tremula: ”Bernarégia végia végia” (alludendo alle origini della sua
nonna Marièt). O, in alternativa ma con la stessa voce, la chiamava
anche “Paciarisotu" (alludendo ironicamente al singolare dialetto
bustocco della mia nonna Virginia Bertani, sua madre).
Maria
Besana nacque nel 1852 (esattamente cento anni prima di me) e morì nel
1934. Rimase orfana molto piccola, con due fratellini più piccoli
ancora. I tre vennero ospitati ed allevati da zii materni che di
cognome facevano Vertemati. Probabilmente dunque la loro mamma era
appunto una Vertemati ma non ne sappiamo il nome proprio. I Vertemati
abitavano in una corte vicino alla vecchia scuola elementare o alla
chiesa di Bernareggio.
La
bisnonna Marièt era analfabeta. Non era mai andata a scuola. Accudiva i
fratellini e a dieci anni andava già a lavorare in filanda a
Germanedo (Lecco). Viaggiava su un carretto trainato da un cavallo.
Partiva alle 4 di mattina del lunedì con le donne e altre bambine.
Portava un fagotto contenente pan giallo, qualche fetta di pancetta e
probabilmente qualche paio di calze. Non le mutande che a quel tempo,
secondo mia madre Enrica, non venivano usate, men che meno dai bambini.
Dopo una settimana di lavoro la piccola Marièt tornava a casa il sabato
sera.
Le
bambine, in virtù delle loro piccole dita, in filanda erano addette
alla ricerca del capo del filo che costituiva il bozzolo. I bozzoli
venivano immersi in vasche d’acqua bollente. Occorreva infatti far
morire il bruco per evitare che divenisse farfalla e bucasse il bozzolo
rovinando così il filo di seta. Così queste bimbe lavoravano tutto il
giorno con le mani nell'acqua bollente.
Mia
madre ricorda che a S. Albino stava anche una certa "Angiulana" che era
originaria di Bernareggio e parente della nonna Marièt. Secondo la
nostra vicina Carmela Ratti in Rossi questa donna era la sua nonna
"Angiòla" (accento sulla o chiusa). Forse fu proprio questa Angiulana a
favorire l'incontro fra Marièt e il bisnonno Davide.
Marièt
arrivò al matrimonio poverissima. Non ebbe neppure i soldi per portare
in dote, come usava tradizionalmente, "al stè" o "baslèta", cioè lo
staio di rame che veniva usato per mondare il riso.
La
nonna Mariet anche se analfabeta era però molto sveglia e brava nei
conti (dote assai apprezzata in negozio). Aveva anche buona memoria.
Ricordava le date di nascita e di morte di tutti. Quando i figli fecero
abbastanza fortuna e dovettero assolvere a vari impegni ed appuntamenti
per via del negozio “da mercanti” e per vari affari immobiliari
intrapresi, la nonna Marièt funzionò da agenda: " Mama regurdivas che 'l
di tal devum andà in dal nudar...". (Mamma ricordateVi che il tal
giorno dobbiamo andare dal notaio”). Ormai anziana e coi nipoti
impegnati alle scuole superiori imparò a leggere le sillabe ma mai ad
assemblarle in una parola compiuta. Così nonostante le sollecitazioni
dei nipoti "ci...me...na" non divenne mai "cinema".
La
bisnonna in compenso era venerata dai figli. In particolare dal mio
nonno Paulìn che peraltro lei considerava il vero capo famiglia. Anche
perché il marito Davide era morto presto e il figlio maggiore Guido dai
dieci/dodici anni in poi visse a Parigi prima e a Zurigo poi, rientrando
in Italia solo per combattere per il suo paese nella prima guerra
mondiale.
A
testimonianza del forte legame tra lei e il figlio mia madre ricorda
che alle volte, al rientro di Paulìn dal lavoro, poteva accadere che la
bisnonna battesse ritmicamente per terra la punta della ciabatta o
dello zoccolo. Era un segno inequivocabile di nervosismo. Allora il
nonno le chiedeva cosa ci fosse e la bisnonna diceva: "La tal (nuora) la
mà mancà da rispèt". Paulin allora convocava le nuore o gli altri
incriminati in seduta plenaria ed annunciava platealmente: "Sia chiaro:
la padruna da ca la cà chi l'è cala dona chi!" (“la padrona di questa
casa è questa donna!”). La questione era chiusa all’istante senza alcun
ulteriore contenzioso.
Altro
analogo rito ricorrente veniva officiato allo spuntare di ogni primizia
dell'orto o del frutteto. Paulin convocava i bambini e in modo chiaro e
didascalico diceva: "Cala magiustra chi (questa fragola, la prima) l'è
da la nona. Guai a chi la tuca!".
Un
rapporto più singolare, come spiegherò dopo, legava la bisnonna al
figlio Demetrio. Demetrio veniva chiamato dai nipoti Ziu Mètar. Credo ci
fosse dell' ironico compiacimento nel gioco di parole, dato che il
metro, inteso come robusta barra di legno di sezione rettangolare nella
casa dei "mercanti" troneggiava immancabilmente sul bancone del negozio
ed era lo strumento di lavoro indispensabile per misurare rapidamente
gli scampoli. A volte serviva perfino per minacciare la paga ai bambini
disobbedienti. Ziu Metar era stato un pò l'artefice dell'impresa
commerciale dei Riva. Il primogenito Guido infatti fin da piccolissimo
faceva il muratore (e solo poi divenne ristoratore e cuoco). Paulìn ne
aveva seguito le orme fin dalla quarta elementare ma poi era diventato
operaio capelé, di cappellificio. Demetrio, forse per conformazione
fisica, forse per vocazione, aveva scelto altre vie professionali. Aveva
iniziato giovanissimo ad organizzare piccole lotterie a premi nelle
osterie. Poi aveva iniziato a vendere "strinc e bindèi" (stringhe
efettucce), girando da ambulante con un cesto di vimini. Inutile dire
che era un oculato risparmiatore ed investitore ed incarnava con la
sorella Chiarina l'anima più “mercantile” dei Riva, mentre Guido e Paolo
erano più idealisti.
- foto di Riva Giuseppe con la moglie Carsani Maria
Giuseppe
invece, che era più giovane, era sensibile, diremmo oggi, alle nuove
tecnologie. Era un bell’uomo, sanguigno e a volte impulsivo. Per inciso
fin da piccolino fu molto irrequieto tanto che una volta, pur essendo
tutto fasciato a mò di mummia nel “bigulòt”, come si usava allora,
riuscì a scendere dalla camera del primo piano lungo la ripida scala a
pioli. Da grande amava molto fare scherzi ai bambini. Una volta, per
esempio, appese all'attaccapanni lo zio Emilio, anche lui fasciato come
usava ai tempi, e lo lasciò li terrorizzato per un bel pò. Esempio ben
seguito da mia madre che amava lasciare il cuginetto Carluccio Guidali,
di tre o quattro anni, appollaiato sulla forcella di un albero
dicendogli: “Finché non smetti di piangere non ti tiro giù!”. Lo Zio
Giuseppe era appassionato soprattutto di meccanica. Aveva la moto e si
occupava della manutenzione dei carri e dei calessi e in seguito delle
auto e dei camion della famiglia. Per un destino beffardo morì ancora
piuttosto giovane cadendo proprio nella buca del suo meccanico di
fiducia a Concorezzo, mentre rimirava il motore del suo camion in
riparazione. Un evento drammatico cui purtroppo dovette assistere il
figlio Mario. I soccorsi furono immediati ma vani.
Tornando
a Demetrio, lo “Zio Metar” aveva sicuramente un certo genio
imprenditoriale ma anche una propensione perfino eccessiva alla
parsimonia. Così controllava puntualmente ogni entrata ed uscita della
famiglia. Le giovani Riva che ormai andavano alle magistrali dalle
Canossiane, "in centro", con la crème della borghesia monzese, erano
costrette a lavare ripetutamente le calze di seta prima di metterle onde
evitare che lo zio si accorgesse che erano nuove. Altrimenti sarebbero
state dure reprimende per l'irresponsabile prodigalità dei parenti.
Proprio
per questa sua inclinazione al controllo (spending rewew, diremmo oggi)
Mètar si era conquistato in famiglia un altro soprannome meno
innocente. E l’artefice del graffiante nomignolo era stato il più
insospettabile dei familiari. Proprio la sua mamma, bisnonna Marièt, lo
chiamava, in sua assenza, il "pètabal" (che potremmo tradurre
pudicamente come "il rompiscatole"). A volte, rivolgendosi alle nuore la
bisnonna diceva: "Adess che gh'è no 'l pètabal fèmm un bel cafè!".
Va
detto a margine che Marièt aveva comunque una certa propensione
all'aforisma icastico, fantasioso ma a volte un po' greve. Un suo
proverbiale motto rivolto ai nipoti era: ”Mangia l'uga (dieresi) ca ta
schigasciat!”. Lasciamo la traduzione all'iniziativa del lettore.
I
figli di Davide e Marièt nacquero quasi tutti in Curt di Fopa. Solo lo
zio Giuseppe nacque nello stanzone sopra il negozio nuovo dei Riva.
Oltre ai quattro maschi (nell'ordine: Guido, Paolo, Demetrio e Giuseppe)
i bisnonni ebbero anche due figlie, Chiara ed Irene. Irene a soli 20
anni morì di tisi. Secondo il nonno Paolo era molto bella e dolce.
Assomigliava a zia Chiarina e a questo punto direi che assomigliava
anche alla sua mamma perché quando ho visto la foto della bisnonna
Marièt giovane mi è parsa identica a Zia Chiarina che ho conosciuto bene
da ragazzino. Irene era molto pia tanto che sembrava dovesse diventare
una suora. Quando i fratelli le rivolgevano parola in modo meno che
cauto lei diventava tutta rossa. Probabilmente era la penultima dei
figli. Il bello è che ho (ri)scoperto la sua esistenza solo di recente
(nell'ottobre 2012) grazie all'albero genelogico stilato da Simone Riva,
figlio di mio cugino Giorgio. Può darsi che me ne fossi dimenticato. A
mia madre Enrica è sembrato strano di non avermene mai parlato anche se
probabilmente una morte così prematura è evento che tutti in qualche
modo cercano di rimuovere. Allora ho chiesto se nonno Paulin avesse
avuto altri fratelli. Enrica mi ha risposto che nonno diceva di non
ricordare ma che probabilmente erano morti due o tre fratellini, “ma
molto piccoli”.
 |
| VERTEMATI MAURO ERA UN CUGINO DELLA NONNA MARIET |
 |
| Francesco Besana, cugino della nonna Marièt |


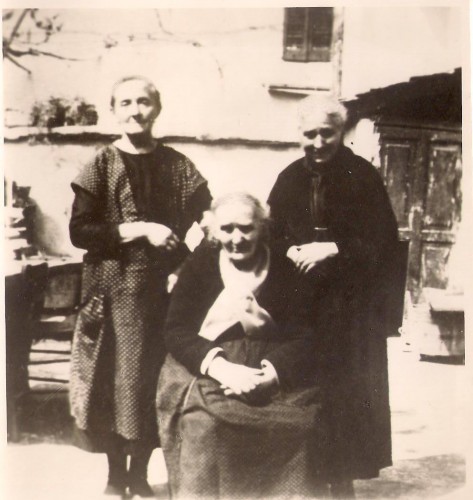
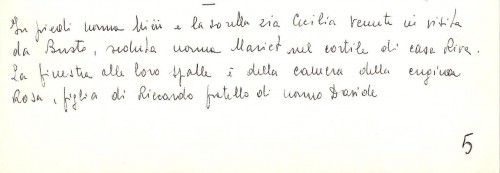


Nessun commento:
Posta un commento